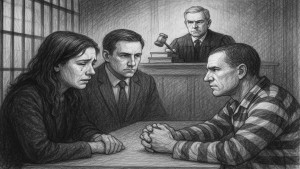Giustizia riparativa e la vittimizzazione secondaria
Premessa
Le recenti vicende giudiziarie legate ad episodi criminosi in danno delle Vittime di Femminicidi, lesioni personali, stalking e violenze nei confronti del sesso debole meritano un’attenta disamina in relazione alle conseguenze derivanti dalla necessaria partecipazione agli accertamenti pre-processuali e processuali ma anche in relazione alla recente Riforma Cartabia, che ha introdotto la possibilità di una definizione bonaria dei procedimenti penali, fondata sul consenso delle Parti ma salvaguardando la partecipazione della Vittima alle attività previste, come si dirà infra.
| Lunedi 10 Novembre 2025 |
In generale, la Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnino ad evitare il fenomeno della c.d. “vittimizzazione secondaria", che consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato derivanti dalle procedure susseguenti ad una denuncia ovvero dall'apertura di un procedimento giudiziario a carico del responsabile.
Tale fenomeno risulta spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le vittima di reati siano scoraggiate alla presentazione della denuncia delle violenze subite dal responsabile ovvero dalle Autorità preposte alla loro tutela.
Per contro, la necessità di intervenire per arginare la diffusione della violenza domestica e di genere destinata a sfociare, nei casi più gravi, nel reato di Femminicidio, come emerge dalle cronache quotidiane impone una risposta coerente di tutte le Istituzioni .
Tuttavia, sebbene non si possa reprimere la violenza domestica ricorrendo alla normativa sanzionatoria penale, non si possono ignorarne gli effetti cagionati dai procedimenti penali in cui la Vittima assume un ruolo fondamentale anche per l’affidamento dei figli minori e la responsabilità genitoriale.
Pertanto, é necessario intervenire garantire l’adozione da parte del Legislatore di provvedimenti coordinati nella consapevolezza che la vera efficacia deterrente per reprimere le condotte di violenza domestica si realizza verificando la sussistenza di tali condotte, a partire dai procedimenti civili e minorili, con sanzioni o misure limitative efficaci a carico del genitore violento.
Inoltre, prescindendo dalle conseguenze civilistiche, occorrerebbe evitare gli effetti di procedimenti sui soggetti coinvolti all’origine della “vittimizzazione secondaria”.
-
La Convenzione di Istambul
L’allarmante diffusione di condotte di violenza domestica nei confronti delle donne, nella gran parte dei Paesi, ha portato all’adozione di numerosi interventi normativi nazionali e sovranazionali per il suo contrasto.
La radice culturale del fenomeno, per lungo tempo tollerato e sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza internazionale con l’aumento del contrasto alla violenza domestica e, più in generale, nei confronti delle donne nell’alveo della tutela dei diritti umani, con la conseguente introduzione di norme puntuali e più efficaci.
La Convenzione del Consiglio d’Europa, meglio nota come Convenzione di Istambul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 giugno 2013, n.77, ha dettato specifiche disposizione per il contrasto ad ogni forma di violenza domestica, imponendo agli Stati di dotarsi di una legislazione efficace e di verificarne in modo costante l’effettiva attuazione da parte di tutti gli operatori ed, in particolare, da quelli appartenenti al sistema giudiziario.
Nel contrasto al fenomeno l’attenzione del Legislatore nazionale si è, quindi, concentrata principalmente, sulla repressione delle condotte penalmente rilevanti, con l’adozione di norme (cfr Legge 19 luglio 2019, n. 69 e succ. mod. al c.d. Codice Rosso), che hanno introdotto risposte sanzionatorie sempre più elevate, scelta certamente idonea a conseguire l’obiettivo prefissato, ma sicuramente non sufficiente, come dimostrato dalla loro incidenza statistica in costante aumento.
Va sottolineato che la pur severa repressione penale di tutte le forme di violenza domestica, l’introduzione in forza delle nuove fattispecie incriminatrici, l’ulteriore inasprimento delle sanzioni già esistenti, non ha, tuttavia, dimostrato di avere l’efficacia deterrente auspicata (!!), come sostenuto dagli stessi Operatori e dalla Dottrina più autorevole.
Ne è riprova il dibattito, ancora in corso, sull’utilizzo del c.d. braccialetto elettronico che ha registrato la inutilità di tale presidio tecnico a tutelare la Vittima, dovuto al suo cattivo funzionamento.
Inoltre, la tendenza a reprimerne solo le manifestazioni più gravi, ha impedito al Legislatore di dedicare analoga attenzione ad un diverso ambito nel quale le condotte di violenza domestica, declinate in tutte le loro forme di violenza fisica, psicologica, economica, hanno la maggiore incidenza nelle relazioni familiari.
Sta di fatto che è all’interno della famiglia che i rapporti fondati sulla prevaricazione e sulla sopraffazione esplicano gli effetti più gravi e devastanti poiché, tra le mura domestiche si concentra il numero più elevato di violenze che hanno la maggiore difficoltà ad emergere come fenomeno di rilevanza penale.
Nelle relazioni insane, basate su rapporti di prevaricazione del partner violento sui familiari, si realizza il cosiddetto “ciclo della violenza” che vede susseguirsi ad una prima fase nella quale si realizzano le condotte preliminari della violenza, quelle in cui seguono fasi di ricostituzione del legame, nelle quali l’autore promette di non reiterare le condotte aggressive, si mostra premuroso e tende ad attribuire la responsabilità a condotte esterne, a volte imputate alla stessa vittima, in modo da riconquistarne la fiducia, anche in nome di una pretesa unità familiare.
In questo circolo, la donna, in posizione di soggezione rispetto al partner (in molti casi anche economicamente), finisce per riprendere la relazione fino al successivo episodio di violenza, in un ciclo ripetitivo che può proseguire per un lungo numero di anni senza alcuna reazione da parte della Vittima tanto meno rivolgendosi alle Autorità.
Sul punto, occorre ricordare che la Convenzione di Istanbul è stata applicata nei procedimenti giudiziari solo dopo la adozione della legge di ratifica nel 2013 nelle decisioni di legittimità della Corte di Cassazione nei procedimenti civili e minorili, che hanno richiamato questa fonte sovranazionale.
Tuttavia, una sottovalutazione del fenomeno nell’ambito dei giudizi civili e minorili ha avuto come conseguenza il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria in danno delle madri e dei figli, esposti a condotte violente non sanzionate a sufficienza, quando non vengano accertate in sede penale.
-
La Definizione della Vittimizzazione secondaria
Una puntuale definizione della “vittimizzazione secondaria” si può rinvenire nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d’Europa secondo la quale «vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima» e colpisce le donne che hanno subito violenza soprattutto in ambito familiare e nelle relazioni affettive.
Invero, la Convenzione di Istanbul obbliga gli Stati a contrastare la vittimizzazione secondaria poiché, in base all’art.18, i Paesi contraenti devono adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
Tale articolo, al comma 3, indica gli interventi finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo“basati su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e che si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secodaria; che mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze; che consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.».
-
La Vittimizzazione nei procedimenti civili e per i minori
In effetti, la forma più ricorrente e più grave di vittimizzazione secondaria può realizzarsi nei procedimenti di affidamento dei figli a causa della mancata applicazione dell’articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale si prevede che «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione».
Anche l’assenza di accertamenti preliminari in merito all’esistenza di condotte di violenza, rinviati alla fase istruttoria, ovvero non compiuti in presenza di accertamenti peritali o indagini dei servizi sociali sulle capacità genitoriali delle parti, produce forme di vittimizzazione secondaria ancora più evidenti nell’adozione dei provvedimenti che regolano l’affidamento del minore, il diritto di visita del genitore non coabitante, e finanche nell’adozione dei provvedimenti c.d. de potestate, di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.
In alcuni casi, tali omissioni possono avere come risultato il mancato accertamento delle ragioni per le quali il figlio minore si oppone alla frequentazione del padre.
Ne consegue che il mancato accertamento delle condotte violente e la conseguente mancata valutazione di tali comportamenti nella adozione delle decisioni per l affidamento dei figli, origina l’emanazione di provvedimenti stereotipati che dispongono l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, senza distinguere tra il genitore violento e la genitrice vittima di violenza.
Inoltre la madre affidataria dei minori, in forza delle decisioni dell’A.G, spesso ostacolate dal genitore violento, subisce un ulteriore pregiudizio per il minore rimasto privo dei necessari interventi di sostegno da parte del coniuge autore della violenza, con il rischio di essere di nuovo esposta ad aggressioni, a pressioni o a condizionamenti.
Altra forma di vittimizzazione secondaria è ravvisabile nell’adozione di provvedimenti relativi al diritto di visita del padre, quando i figli minori siano collocati in via prevalente presso la madre.
Sul punto va sottolineato che, anche in questo caso, il mancato accertamento della violenza o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenza la mancanza di tutele per i figli e per le madri, con il rischio che comportamenti violenti si realizzino di nuovo o in danno dei minori, nei periodi di frequentazione, o in danno della madre, nel momento in cui il padre prelevi o riceva i minori per l’esercizio del diritto di visita.
Sul punto la Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, detta specifici obblighi positivi a carico delle Paesi contraenti, al fine di scongiurare tale rischio, prevedendo all'art. 15, che sia assicurata “una formazione specifica alle figure professionali che si occupino di vittime e di autori di atti di violenza”
Peraltro, a volte gli stessi Operatori coinvolti nei diversi ruoli nei procedimenti giudiziari che hanno per oggetto domande relative ai figli minori, causano, sebbene involontariamente, forme di vittimizzazione secondaria della madre e soprattutto del minore.
Per scongiurare tutti gli effetti negativi legati al mancato accertamento della violenza, occorre verificare: la compatibilità dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul con la ordinaria applicazione della disposizione sull’affidamento condiviso compiuta nei giudizi civili in Italia e relativi:
a) al bilanciamento del diritto alla bigenitorialità con i diritti fondamentali del minore alla salute, sicurezza, libertà di autodeterminazione;
b) all'eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta sindrome della alienazione parentale, o a sindromi analoghe quali la sindrome della “madre malevola”, della “madre manipolativa”, che non hanno alcun riconoscimento nella comunità scientifica.
Sul punto, la Dottrina prevalente sostiene che, laddove emerga una forma di violenza domestica o di genere, rientrante nell’ambito applicativo della Convenzione di Istanbul, dovrebbe essere escluso l’affidamento condiviso, favorendo l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori in presenza di condotte pregiudizievoli poste in essere dall'altro.
Va ancora sottolineato che il diritto alla bigenitorialità deve essere sempre subordinato all’interesse superiore del minore, diritto quest’ultimo di rango costituzionale, che in ogni bilanciamento di interessi deve essere riconosciuto e tutelato quale preminente rispetto agli altri.
Invero, l’art. 30 della Costituzione, unitamente agli artt.2,3 e 29, impone prima il dovere e riconosce poi il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
Anche la Corte EDU ha riconosciuto il superiore interesse del minore a parametro nell’applicazione dell’art. 8 della CEDU, sia quanto agli obblighi negativi, sia quanto agli obblighi positivi laddove assume un ruolo determinate l’opinione del figlio, che discende del suo diritto ad essere ascoltato.
Inoltre, la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori e a vivere in modo sereno oltre al diritto del genitore non affidatario a mantenere rapporti con il figlio.
Infine, la Corte ha ricordato che il citato art. 8 deve essere interpretato con riferimento all’art. 31 della Convenzione di Istanbul per cui colui che ha azionato la violenza non può essere soggetto di una norma a tutela della sua vita familiare, che è stata messa in pericolo dalla sua condotta.
-
La vittimizzazione nel processo penale
Da quanto innanzi esposto emerge con chiarezza come il mancato coordinamento tra le Autorità Giudiziarie civili e penali possa produrre gravi forme di vittimizzazione secondaria per le vittime di violenza domestica qualora le stesse siano chiamate a rievocare le violenze subite dinanzi a ciascuna delle Autorità indicate, siccome esposte a tensioni e sofferenze, nonché al rischio di decisioni tra loro non coordinate ed in taluni casi divergenti.
Nel processo penale la Vittimizzazione si riferisce sia alle conseguenze dirette del reato (vittimizzazione primaria) sia alle conseguenze negative derivanti dal modo in cui la vittima viene trattata dalle Istituzioni (vittimizzazione secondaria).
La vittimizzazione secondaria può manifestarsi attraverso un racconto che colpevolizza la vittima, un eccessivo formalismo delle procedure, lungaggini burocratiche, mancanza di comunicazione e una mancata valutazione dei suoi diritti e bisogni.
Nella Vittimizzazione primaria vi sono effetti diretti del reato sulla vittima, che includono danni fisici, psicologici, economici e sociali.
Per contro, la Vittimizzazione secondaria si verifica quando la vittima rivive le sofferenze a causa di procedure istituzionali e del modo in cui viene trattata, come ad esempio a causa di:
-
Colpevolizzazione della vittima: si tende a far ricadere sulla vittima la colpa dell'accaduto, suggerendo una sua corresponsabilità.
-
Procedura processuale: le lungaggini, l'incertezza e l'eccessiva formalità delle procedure possono essere stressanti e invalidanti.
-
Mancanza di attenzione: il mancato ascolto o l'incredulità da parte delle istituzioni possono causare ulteriore trauma.
-
Difficoltà burocratiche: la necessità di affrontare complesse procedure per ottenere giustizia, anche solo per il rimborso delle spese, può essere un peso aggiuntivo.
Tuttavia sono assicurati nel procedimento alcuni diritti e tutele per la Vittima già contenuti nella Direttiva Europea 2012/29/UE e ribaditi nel testo di Riforma della Giustizia in vigore, tra cui rientrano:
-
Diritto all'assistenza legale: la vittima ha diritto all'assistenza di un avvocato, anche con il patrocinio a spese dello Stato se non abbiente.
-
Diritto al risarcimento dei danni
-
La Vittima ha diritto ad ottenere una decisione sul risarcimento del danno entro un ragionevole lasso di tempo.
-
Diritto alla restituzione dei beni: i beni sequestrati devono essere restituiti senza ritardo una volta che la decisione dell'autorità giudiziaria lo consente.
-
Diritto di presentare denuncia e querela:
La persona offesa può presentare querela per avviare un procedimento penale. In questo contesto grande rilevanza ha assunto anche la istituzione della Giustizia Riparativa delineata dal Legislatore a tutela dei diritti processuali della stessa innanzi richiamati.
-
La Giustizia Riparativa e la Vittimizzazione
Di recente la Dottrina ha cercato di individuare nella Giustizia Riparativa un possibile rimedio delle liti penali generate da comportamenti lesivi nei confronti del coniuge ovvero più in generale delle Donne Vittime di reato (v. F. Cacace in Riv. Giurisrudenza Penale, ottobre 2025)
Tale ricerca emergerebbe dalla lettura della Direttiva Europea 2012/ 29/UE, posta a base della Riforma Cartabia per un concreto riconoscimento dei diritti delle Vittime in ambito processuale laddove, sul presupposto che i servizi di giustizia riparativa possano essere di “grande beneficio per le vittime” senza sottovalutare i rischi di vittimizzazione per la stessagli
Da questo assunto emergerebbe l’esortazione.rivolta agli Operatori dei servizi di giustizia riparativa, di porre al centro del loro operato tre elementi: a) gli interessi e le esigenze della vittima; b) la riparazione del danno da essa subito; c) l’evitare ulteriori danni.
A tal fine va ricordato che la Direttiva citata afferma al Considerando (46) “I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni”.
Sarebbe opportuno, quindi, che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni.
Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato.
Inoltre, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito.
A tal fine, in linea di principio i procedimenti di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per motivi di interesse pubblico.
Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale”.
Lo stesso Consuderando contiene l’invito a tenere conto di altri fattori quali: il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima che potrebbero che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento riparativo, da interpretarsi come funzionale ad evitare i rischi di vittimizzazione.
Si tratta, quindi, di effettuare in vista dello svolgimento dei programmi di Giustizia riparativa quella valutazione individuale delle vittime già prevista dall’articolo 22 della citata Direttiva e finalizzata proprio a prevenire fenomeni di vittimizzazione.
Quindi, anche i servizi di Giustizia riparativa dovrebbero procedere ad una valutazione individuale delle vittime, per prevenire l’assoggettabilità della Vittima a fenomeni di vittimizzazione.
Pertanto, benché le misure da adottarsi per rispettare le condizioni minime meglio indicate dall’art.12 citato siano ritenute dal Legislatore europeo di per sé sufficienti a garantire la protezione delle vittime dalla vittimizzazione, le stesse cautele andranno in ogni caso integrate da una tempestiva (e previa) valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione delle quali necessitano.
Tale tesi trova conforto anche nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) 8 che riprende alcune delle condizioni sopra viste ma aggiunge alcune, per l’appunto raccomandazioni, interessanti e rilevanti ai fini della considerazione dei rischi di vittimizzazione connessi ai percorsi di giustizia riparativa,
Infine, va ricordato che la Relazione illustrativa al D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 150 afferma che l’intero testo normativo si ispira ai principi di Giustizia riparativa sanciti a livello internazionale ed europeo, e precisa che “si è fatto riferimento ai principi e alle disposizioni” della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) 8, per quanto concerne le previsioni atte ad impedire i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione.
Secondo la stessa Relazione, sull’art 43 del D. Lgs n. 150/2022,sostiene che “nel rispetto dei principi sovranazionali si sarebbe tenuto conto in particolar modo del Considerando 46 che, avverte che “I servizi di giustizia riparativa … richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni”
Tuttavia, non si comprende come tale considerando sia stato preso in considerazione dall’articolo 53 del D. Lgs citato, che, invece, contiene soltanto l’elencazione dei programmi .di giustizia riparativa.
In definitiva sostenere, in tale articolo, che la minimizzazione dei rischi di vittimizzazione secondaria sia assicurata dall’intervento di due mediatori, non appare molto condivisibile
-
Conclusioni
La Direttiva 2012/29/UE si preoccupa delle salvaguardie per l’accesso ai servizi di giustizia riparativa da parte della Vittima per il concreto rischio di vittimizzazione secondaria, prevedendo il riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell’autore del reato come pre-requisito per la partecipazione ai programmi riparativi mentre in senso opposto operano le salvaguardie in favore dell’autore del reato a tutela della presunzione di non colpevolezza il tutto sulla base del consenso delle Parti ad accedere al procedimento riparativo.
Sul punto la Dottrina ha osservato che, alla fine, il legame tra giustizia riparativa e processo penale non favorisce l’approfondimento della relazione vittima-autore e, anzi, le esigenze di tutela dell’accusato finiscono per accentuare il profilo garantistico e, a tratti, formalistico della stessa procedura riparativa.
La necessità di garantire il principio di presunzione di non colpevolezza nel procedimento penale ha indotto il Legislatore italiano ad escludere qualunque riconoscimento dei fatti del caso da parte dell’autore della offesa che già prefigura un evidente richio di vittimizzazione secondaria.
La volontarietà dell’accesso e il consenso della vittima potrebbe non essere sufficiente ad evitare rischi per la vittima che potrebbe non essere in grado di valutare da sola tale rischio senza poter contare sulla presenza del proprio difensore
La possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa per tutti i tipi di reato rischia poi di porre nel nulla le cautele previste dal Legislatore per le vittime che godono di una tutela speciale nel processo penale che, invece, nella Giustizia riparativa, vengono tutti indistintamente ammessi.
Ulteriore occasione di vittimizzazione secondaria si configura nel ricorso alla vittima surrogata, laddove non vi sia il consenso della vittima diretta.
A queste incognite e domande si cerca di dare una risposta e, prima fra tutte, se si possa affermare che il legislatore italiano ha adottato, come raccomanda l’art. 12 della Direttiva 2012/29/UE, tutte le “misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa”
L’auspicio è che, laddove si parla di incolumità della Vittima, si faccia riferimento non solo a quella fisica ma anche quella psicologica che potrebbe derivare da un contatto tra le parti.
Certamente si può condividere l’opinione che questa sarebbe stata la sede più appropriata nella quale il Legislatore avrebbe dovuto richiamare l’importanza di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizza zione secondaria e ripetuta, derivanti da possibili intimidazioni e di ritorsione, come evidenziate dalla stessa Direttiva 2012/29/UE.
Tale valutazione, in ogni caso, non potrebbe essere rimessa al mediatore, proprio a tutela della sua funzione terza rispetto alle parti.
D’altra parte, non sembra che vi siano alternative a quella effettuata dall’Autorità Giudiziaria, alla luce di quanto dispone il co.3 dell art. 129 bis del CPP, il che costituirebbe, ancora una volta, una illegittimità della norma procedurale per la possibile disparità di trattamento ex art. 3 della Cost. e per la non impugnabilità della Ordinanza ammissiva o di rigetto da parte della Vittima.