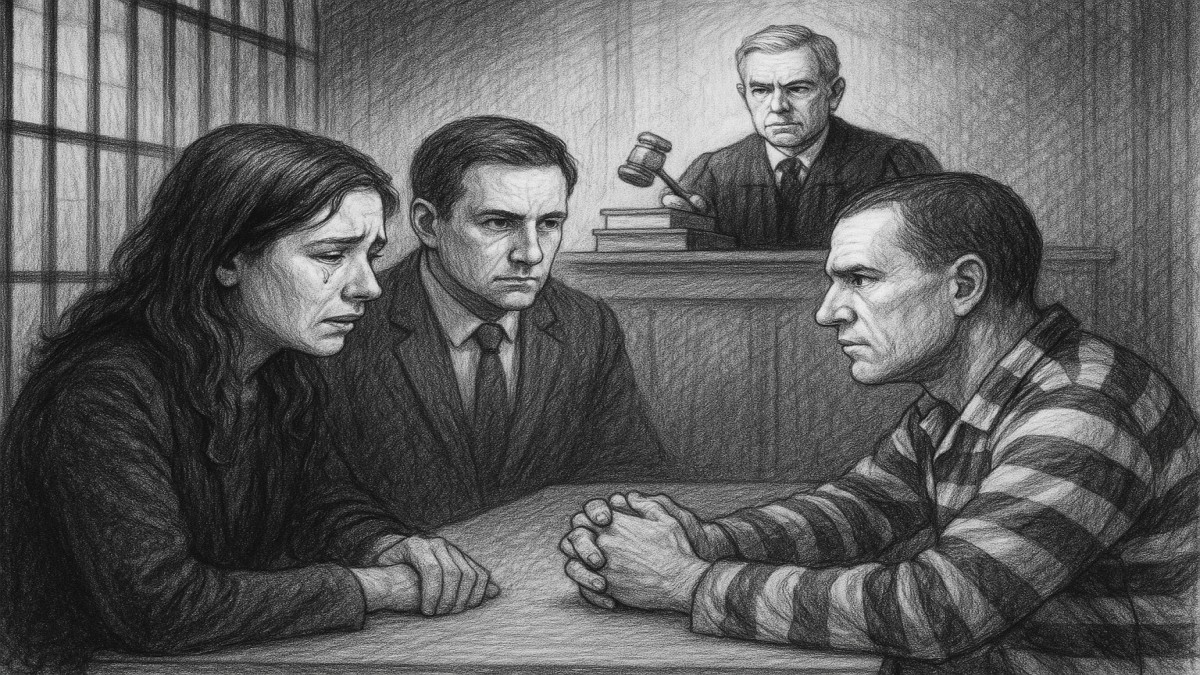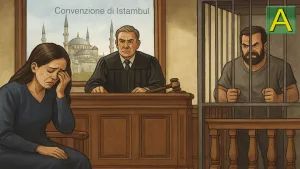Giustizia Riparativa e altre condotte riparatorie nella giurisprudenza
a. Considerazioni introduttive
I numerosi problemi che affliggono la Giustizia in Italia, nonostante varie Riforme, finiscono con il deprimere la necessità di assicurare sia agli imputati che alle parti offese una rapida decisione anche ai fini del risarcimento dei danni subiti dalla Vittima di reato.
| Giovedi 24 Luglio 2025 |
Il superamento dell’ottica punitiva e riabilitativa per quella riparativa corrisponde, di fatto, ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie che, pur mantenendo intatti gli aspetti della responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e, nel contempo, ad una migliore tutela degli interessi della vittima del reato, persona singola o Società nel suo complesso.
In quest’ambito va collocata la Giustizia Riparativa con la Mediazione Penale, introdotti dalla Riforma Cartabia, in base alla quale reo e vittima, adeguatamente supportati, hanno la possibilità di partecipare alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio penale che ha i suoi tempi tecnici, mai definibili a priori, e che il più delle volte non apporta alcun bemeficio alla Vittima di turno.
Con il nuovo Istituto ha trovato attuazione la Direttiva 2012/29/UE che stabilisce norme minime«in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», sostituendo la meno ampia e articolata Decisione-quadro 2001/220/GAI UE«sulla posizione della vittima nel procedimento penale».
In particolare, l’art.2 della Direttiva definisce come «vittima» «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» estendendo la definizione sino ad includervi anche la c.d.vittima indiretta (invero, non contemplata dalla Decisione Quadro citata), ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».
Inoltre, la stessa Direttiva, all’art.2,co.1,d), definisce come «giustizia riparativa» «ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale[tiers indipendant/impartial third party]».
Si tratta di un procedimento orientato alla riparazione delle conseguenze del reato, pressoché identico a quello contenuto nella Raccomandazione n°(99) 19 «sulla mediazione in materia penale» e riferito, dunque, solo a questo particolare «servizio di giustizia riparativa».
L’Unione Europea, infatti, preso atto che il concetto e la portata della mediazione in materia penale si sono nel tempo ampliati ed è emersa la necessità di una più ampia categoria, fa riferimento ai “servizi di giustizia riparativa”, «fra cui ad esempio, la mediazione [mediation entre la victime et l’auteur de l’infraction/victim-offender mediation], il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisu rativi».
Sempre in base alla Direttiva, l’accesso a tali servizi deve avvenire almeno in presenza delle seguenti condizioni:
a) si può ricorrere ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, tenendo conto della sua sicurezza e basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso ed al suo potenziale esito, oltre ad informazioni sulle modalità di controllo della esecuzione dell’eventuale accordo;
c) l’autore del reato deve riconoscere i fatti essenziali del caso;
d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
e) tutte le discussioni che hanno luogo nell’ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere divulgate solo con l’accordo delle parti o per preminenti motivi di interesse pubblico.
Inoltre, il provvedimento riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l’arco processuale ivi compresa la fase dell’esecuzione penale che sono costituiti :dal diritto ad ottenere dettagliate informazioni sul proprio casomal diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai significativi diritti di partecipazione al processo penale, al diritto ad una protezione della sua persona nel corso del procedimento.
Tra i presupposti in concreto alla Vittima vi é «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa» e va sottolineato che può essere estesa a tutte le fattispecie di reato atteso che il Legislatore non ne ha limitato l’accesso che può avvenire in ogni stato e grado del giudizio e nella fase della esecuzione penale.
Pertanto, la giustizia riparativa, come emerge dai numerosi contributi dottrinali, può, quindi, essere definita come “un modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo” sulla base di tre pilastri fondamentali:
-L’attenzione al danno e ai bisogni della vittima;
-L’obbligazione a riparare che nasce da un percorso di auto-responsabilizzazione dell’autore del reato (percorso che non deve essere imposto ma volontario);
-Il coinvolgimento delle parti nella soluzione del conflitto.
Tali aspetti essenziali sono stati presi in considerazione anche dalle Nazioni Unite, che, nel documento “Basic Principles on the use of restorative justice program mes in criminale matters”, adottato nel 2002,hanno elaborato una nozione di giustizia riparativa che poco si discosta da quella sopra menzionata:“restorative process means any process in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime, participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator. Restorative process may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles”.
La riconciliazione con la vittima, attraverso una sua partecipazione diretta al procedimento, avviene attraverso la riparazione di ciò che è stato leso, la responsabilizzazione di colui che ha commesso l’illecito, la possibilità di individuare risposte al reato diverse da quelle tradizionali, costituiscono la finalità necessarie in una realtà nella quale si cerca una soluzione che riporti alla risocializzazione e alla rieducazione dell’imputato, più che a una sua punizione, ma anche ad una efficace deflazione dei giudizi tenendo conto degli interessi della Vittima di reato.
b. I precedenti strumenti legislativi
Fino alla introduzione della Riforma, gli strumenti di restorative justice contemplati dal nostro Ordinamento sono stati scarsi e non disciplinati in modo organico mentre risulta ancora parzialmente disapplicata la citata Direttiva 2012/29 EU, che prescrivendo garanzie minime nei confronti delle Vittime di reato, ha stabilito che “i Paesi membri debbano dotarsi, in conformità del proprio Ordinamento penale, di programmi di giustizia riparativa che favoriscano non solo il raggiungimento di risarcimenti, ma soprattutto la partecipazione attiva di reo, vittima e comunità alla risoluzione di questioni derivanti dal reato, in modo libero e per mezzo della mediazione di un terzo imparziale”.
Si deve, purtroppo, evidenziare che il D.Lgs.212 del 2015, emanato per l’attuazione della Direttiva, aveva inciso quasi unicamente sulle norme relative alla presenza dell' interprete durante il processo penale e in fase di esecuzione della pena, oltre ad aver introdotto i nuovi articoli dal 90 al 90-quater del c.p.p. relativi alle informazioni a cui ha diritto la persona offesa dal reato.
Inattuata a lungo è stata anche la Raccomandazione (99) 19,innanzi citata, sulla Mediazione in materia penale, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999,che, invece, ha costituito un input fondamentale per lo sviluppo della restorative justice in altri Paesi Europei.
Tuttavia, il Legislatore, prima di avviare la Riforma organica della materia, come innanzi ricordato, aveva introdotto alcuni Istituti in diverse disposizioni legislative.
Invero, con l’art.17 lett.h) della Legge Delega 468/1999 il Legislatore aveva già imposto al Governo la “previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno”
In base a tale norma venne approvata la Legge sulla competenza penale del giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000) prevedendo, all’art. 29,nel caso di reato perseguibile a querela, che il Giudice promovesse una conciliazione tra le parti, anche avvalendosi dell’attività di mediazione di strutture pubbliche presenti sul territorio ed, in caso di successo, una conseguente remissione della querela (o la rinuncia al ricorso immediato al giudice ex art. 21 che produce gi stessi effetti) con la relativa accettazione.
Inoltre, la legge n. 67 del 2014 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio), estendendo la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova del processo minorile anche agli imputati per reati sanzionati con pene fino a 4 anni di reclusione, aveva stabilito che i programmi di trattamento, allegati all’istanza di sospensione, prevedes- sero, come sancito dall’28,DPR 448/1998 del processo minorile, ”condotte riparato rie e la mediazione con la persona offesa (art. 4)” con la conseguenza che l’esito positivo della prova comportava l’estinzione del reato.
Sia nel caso della legge 274/2000 che nella messa alla prova prevista dalla legge 67/2014,per il Legislatore la Mediazione assumeva natura essenzialmente defila tiva dei giudizi penali in corso.
Un sia pur generico riferimento alla necessità di mediazione con la vittima, si può ravvisare anche nella legge n.354/1975 sull’Ordinamento penitenziario che prevede, tra le prescrizioni dell’affidato in prova al servizio sociale, che questi “si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”(art. 47);atteso che la misura alternativa andava adottata sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato.
Tale previsione va vista in relazione al contenuto dell’art. 27 del Regolamento penitenziario (DPR230/2000) relativo alla “osservazione della personalità” del con dannato, che prevede che l’Equipe di trattamento operante in carcere svolga con questi una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e “sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato”, incluso il risarci mento dovuto alla persona offesa”.
In tale contesto va annoverata anche l’introduzione della nuova causa estintiva del reato di cui all’art.162-ter c.p., per “favorire la rapida fuoriuscita dal circuito penale degli imputati per i reati ritenuti meno gravi, attraverso attività riparatorie”, di cui infra, come pure la Delega al Governo per il riordino della proce dibilità a querela di taluni illeciti, poi attuata con la Riforma Cartabia
Da ultimo va ricordato che la Commissione Grosso, istituita per la riforma del Codice Penale nel 1999,ritenne compatibile con la tenuta general-preventiva del sistema penale la previsione di cause di non punibilità sopravvenuta collegate «a condotte di riparazione dell’offesa realizzate entro soglie temporali che assicurino una reintegrazione utile, perché tempestiva, dell’interesse offeso dal reato, e consentano di ravvisare nella condotta riparatrice un ritorno all’osservanza del precetto violato».
Sin qui lo stato dell’opera del Legislatore prima della Riforma introdotta con il DLgs 150/2022, innanzi richiamata.
c. L’estinzione del reato ex art 162 Ter CP
Un particolare rilievo assume il ricorso al procedimento di estinzione introdotto con l’art.162 ter CP.
Con la Legge n.103/2017 (cd.Riforma Orlando) il Legislatore ha introdotto, all’art. 162-ter c.p., una nuova causa di estinzione del reato dichiarata dal giudice “quando l’imputato (abbia) riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e (abbia) eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato […]”.
Tale innovazione è, comunque, avvenuta anche sulla spinta dalle esigenze di favori re un ristoro delle giuste pretese risarcitorie della vittima, ed è finalizzata a valorizzare il cd. “pentimento reale”quale presupposto della causa estintiva del reato
Si tratta quindi di una sorta di “ravvedimento operoso”successivo all’illecito compiuto, attraverso una condotta dell’imputato in funzione riiparatoria dell’offesa cagionata, che prevede che lo stesso abbia “riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e (abbia) eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato anche attraverso un’offerta reale (e successivo deposito), ai sensi degli articoli 1208 e ss. del codice civile” per ottenere la estinzione del reato..
Tale offerta, laddove non sia accettata dalla persona offesa, è sottoposta al vaglio del giudice il quale ne deve riconoscere la eventuale congruità a titolo di riparazione del danno cagionato.
La norma assume, quindi, la veste di una effettiva causa di estinzione del reato di natura soggettiva come tale applicabile al solo imputato ed, in caso di concorso, non estensibile al correo ove inadempiente.
Tale offerta avvenendo in un momento in cui il reato si è già perfezionato ed incidendo sulla punibilità in astratto per effetto del ritorno del reo “nel terreno della legalità”, risulta, tuttavia, applicabile ai soli reati procedibili a querela di parte (rimettibile) e configurabile in almeno tre diverse varianti:
a) condotte riparatorie ed eliminatorie delle conseguenze dannose del reato entro il termine dell’apertura del dibattimento;
b) condotte riparatorie realizzate mediante presentazione di offerta reale e successivo deposito (artt. 1208 e ss. c.c.);
c) condotte riparatorie con concessione del termine (co.2 dell’art. 162-ter c.p.) per l’imputato che dimostri di non aver potuto adempiere a tali condotte, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine dell’apertura del dibattimento.
In tale ipotesi, il giudice può fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per permettere all’imputato di provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
Tuttavia, l’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art.35 del citato D.Lgs. 274/2000 e l’analoga estinzione decretata dal giudice ai sensi del nuovo art.162-ter, c.p.non possono, invece, essere considerati esempi di giustizia riparativa mancando il requisito del consenso della vittima, che costituisce, invece, il presupposto essenziale della Riforma Cartabia con la Mediazione Penale.
Come afferma la Dottrina (v.Cocco, Una (prima) giurisprudenza sulla estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, in Riv Diritto penale, Giugno 2025) l’Istituto previsto dall’art. 162 ter c.p. ha generato una significativa giurisprudenza di legittimità, consolidata su alcune soluzioni relative alla disciplina che tendono a restringerne l’applicazione e che sembrano indicare un difetto di com prensione della natura innovativa quanto deflattiva attribuita alle condotte riparatorie poste in essere da tale norma “ante litteram”.
Il percorso riformatore, in cui si sono inserite le istanze politico-criminali della c.d. giustizia riparativa, avrebbe, quindi, previsto l’introduzione all’art. 162 ter c.p. come un istituto di carattere generale per la estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie in taluni casi.
Per tale ragione esso va inquadrato tra gli Istituti della non punibilità sopravvenuta per fondamento e struttura, nonché per la pacifica estraneità alle istanze conciliative, proprie della giustizia ripartiva, che si avvale di un diverso procedimento.sebbene più complesso, esteso a tutte le tipologie di reato e con maggiore efficacia per le ragioni delle Vittime ai fin del ristoro dei danni. .
Per contro, l’istituto in commento collega la non punibilità alle restituzioni o alla integrale riparazione del danno provocato in termini piuttosto stringenti con riferimento ai soli reati perseguibili a querela, per i quali è ammessa la remissione, basato sul principio di sussidiarietà esterna .
Infatti, in base a tale principio, il diritto penale può utilizzarsi a tutela dei beni giuridici solo quando gli altri sistemi di tutela falliscono, e nella specie, con la previsione della non punibilità a seguito del comportamento restaurativo post delittuoso.
Lo stesso assoggettamento dei reati procedibili a querela pare espressione di tale principio di sussidiarietà esterna, con riguardo a reati dei quali si riconosce un interesse pubblico al perseguimento, anche in ragione della natura del bene tutelato, esclusivamente su impulso della persona offesa, presupponendo, dunque, la utile composizione in sede extrapenale o, comunque, una complessiva valutazione di irrilevanza penale dell’offesa effettuata da chi ne é vittima, in sostanza riconoscendo un ruolo al diritto penale solo quando la persona offesa non trovi alternative di soddisfazione extrapenali o, comunque, ne reputi essenziale l’intervento.
In tale direzione assume particolare significato il termine apposto dalla norma alla condotta riparatoria, che costituisce un carattere tipico della non punibilità sopravvenuta, la quale, nel riconoscere il valore della regressione offensiva e per rispondere al principio di ragionevolezza, ne subordina la rilevanza a precisi limiti temporali, che assicurino la reintegrazione utile dell’offesa o la eliminazione del pericolo ricollegabili alla minaccia edittale in modo tale che le relative condotte possano apparire come osservanza, sia pure tardiva, del precetto violato, con l’effettiva salvaguardia della esigenza di prevenzione generale (v.Cocco, op citata).
L’importanza del termine da ossservare è ribadita anche dalla previsione di una eventuale proroga, assoggettata all’esito positivo della stessa ed in base al quale il giudice dichiara l’estinzione del reato (co. 2 e 3).
Inoltre, una volta posta in essere nei termini assegnati la condotta riparatoria, il giudice può valutarla congrua all’esito del dibattimento così come in sede di gravame .
In definitiva, il Legislatore ha affiancato alla perseguibilità a querela del reato, le condotte riparatorie quale causa di non punibilità, ambedue le figure basate sul principio di sussidiarietà esterna, determinando per i reati interessati una sorta di status del tutto peculiare, molto prossimo alla depenalizzazione.
d. I requisiti della condotta riparatoria ex art 162 ter CP.
Dopo questa disamina di carattere generale, serve chiedersi quali sono i requisiti delle condotte riparatorie che possono portare alla estinzione del reato in base alla norma.
Tra le cause di non punibilità sopravvenute, è, innanzitutto, necessario che la con dotta riparatoria sia volontaria, ovvero che l’agente possa tenere un comporta mento differente in assenza di costrizioni che lo inducano alla condotta sopravve nuta, perché, in caso contrario, non potrebbe avere alcuna efficacia, seppure tardi va, sulla pena edittale .
Le previsioni di non punibilità fanno leva anche sui calcoli utilitaristici del soggetto agente, sebbene questi non ne costituiscano il fondamento, e necessitano di una condotta volontaria correlata alla natura riparatoria delle stesse nonché all’abi tuale previsione di un limite temporale da osservarsi, così come del resto la stessa finalità general preventiva della previsione incriminatrice
Non è necessario, invece, che la condotta esprima ravvedimento, inteso come trasformazione in senso socialmente o moralmente apprezzabile della personalità dell’agente sebbene ill comportamento in questione rappresenti, in tutta evidenza, proprio la ideale integrazione dell’istituto, che espressamente richiede la sola volontaria restituzione in taluni casi atteso che l’immediata restituzione del bene rispetto a quella che avvenga successivamente.a seguito del rinvio a giudizio prima della apertura del dibattimento, con un inutile aggravio.
In altri giudizi, è evidente che si confonde spontaneità con volontarietà, poiché l’arresto in flagranza, laddove comportante ipso facto e senza il contributo del reo il recupero del bene illecitamente sottratto, esclude la sussistenza di una condotta riparatoria atteso che il recupero operato dalle Forze dell’Ordine, non per inizia tiva degli autori della sottrazione, è irrilevante ai fini dell’ applicazione dell’art. 162-ter c.p.
In tema di condotte riparatorie vale l’importante principio espresso dalle Sezioni unite,22.1.2009,n. 5941,secondo cui il Legislatore privilegia non il concreto soddisfacimento degli interessi della persona offesa del reato, bensì l’aspetto psicologico e volontaristico della riparazione, ossia «la condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua attenuata capacità a delinquere».
Inoltre, la causa di non punibilità in esame, si distacca da tale impostazione, non mutuando la formulazione dell’art.35, d.lgs. n.274/2000,relativo ai reati di competenza del Giudice di pace, perché non contempla alcun riferimento a valuta zioni del giudice relative al soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato ma ricollega tout court la estinzione del reato alla sussistenza delle condotte riparatorie.
e. Le differenze con la giustizia riparativa
Occorre ribadire, comunque, la evidente irrilevanza nell’art. 162 ter c.p. delle tematiche conciliative e vittimologiche ed ancor più di quelle special preventive concernenti il riconoscimento di una minore capacità a delinquere e della risocializzazione del reo, opportunamente escluse da ogni rilievo dal suo tenore letterale, che oltretutto attribuisce alle parti un ruolo marginale poiché debbono essere solo sentite.
L’istituto in esame è, infatti, applicabile esclusivamente in ragione della presa d’atto da parte dell’Ordinamento della restaurazione del patrimonio del danneg giato.
Va detto che le restituzioni non ammettono un sindacato giudiziale in senso proprio, ma esclusivamente il mero accertamento del fatto ed, in difetto delle restituzioni, l’alternativa integrale riparazione del danno può essere riconosciuta dal giudice (co. 1, parte 2), sussistendo in tal caso una componente valutativa più pregnante, anche a seguito di offerta reale ex artt. 1208 c.c. e seguenti formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa.
Anche su questo punto in giurisprudenza sembra però affermarsi una lettura restrittiva, con la pretesa della presenza dei requisiti previsti dagli artt. 1208 e 1209 c.c.
L’irrilevanza nell’istituto in esame comporta anche l’irrilevanza dell’origine dei mezzi necessari alla riparazione, perché la condotta riparatoria non deve esprimere un soggettivo ravvedimento del reo desumibile dal suo sacrificio patrimoniale, nonché delle modalità di formalizzazione della attività di reinte grazione, a cui può provvedere anche un terzo purché nell’interesse dell’imputato .
Correttamente, in particolare, si afferma in giurisprudenza che l’art. 162 ter c.p. «è applicabile anche nel caso in cui il danno sia integralmente risarcito dalla com pagnia assicuratrice dell’imputato»
Non v’è dubbio, invece, che la ricezione da parte della vittima di un risarcimento del danno, nei cui confronti si sia assicurato, da parte della propria assicurazione privata o pubblica sia irrilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame
È, tuttavia, necessario, in caso di risarcimento, l’accertamento giudiziale della con gruità della somma offerta nel contraddittorio delle part sebbene tale valutazione
da parte del Giudice, che è richiesta dalla norma anche nel caso dell’accettazione da parte della persona offesa, preveda la verifica della sussistenza degli elementi integranti la causa di non punibilità sopravvenuta e, dunque, anche dell’integrale riparazione del danno cagionato dal fatto illecito sebbene la persona offesa può con la remissione della querela, che se non è ricusata dal reo estingue il reato (152 c.p.,155 c.p.), escludere ogni interferenza giudiziale sulla valutazione della congruità del risarcimento.
Va consolidandosi in giurisprudenza la esclusione della subordinazione della dichiarazione dell’estinzione del reato per condotta riparatoria intervenuta prima del dibattimento alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato, come invece richiesto dalla procedura prevista dall’art. 469 c.p.p., che riguarda le ipotesi di proscioglimento predibattimentale, tra le quali compare la declaratoria di intervenuta estinzione del reato, assoggettata alla condizione, a pena di nullità di ordine generale, della citata non opposizione di pubblico ministero e imputato previamente consultati .
In definitiva, l’Istituto introdotto con l’art 162 ter c.p. costituisce un importante riconoscimento della non punibilità sopravvenuta, ed é espressione del principio di sussidiarietà esterna in tema di tutela dei beni giuridici delle Vittime.
-
Conclusioni
L’accertamento della responsabilità penale, oltre che all’applicazione della pena, porta con sé l’ulteriore conseguenza, prevista dall’art. 185 c.p., dell’obbligo alle “restituzioni, a norma delle leggi civili, nonché al risarcimento del danno, cui sono tenuti, oltre al colpevole, le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”, in funzione di ristoro del pregiudizio arrecato al danneggiato in occasione della commissione del reato.
Considerati i tempi biblici della Giustizia Penale, la Mediazione Penale offre la possibilità di addivenire ad una composizione della controversia senza la costituzione di parte civili e gli oneri dalla stessa derivanti, come pure offrirebbe all’autore del reato la possibilità di beneficiare dei c.d. riti alternativi e delle c.d. pene alternative che, insieme all’attenuante dell’avvenuto risarcimento, possono contribuire alla deflazione delle cause pendenti.
La tutela delle vittime di reato attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e costituisce uno degli aspetti essenziali cui occorre avere riguardo, sia nell’ambito del procedimento giudiziario sia soprattutto nelle fasi preliminari e successiva ad esso.
Con riguardo a tutti questi aspetti, nel nostro Paese si verificano, purtroppo, ancora molti ritardi, malfunzionamenti e colpevoli inadempienze.
I servizi di assistenza extra-processuale alle Vittime appaiono disomogenei sul territorio nazionale mentre potrebbero favorire una ricomposizione dei conflitti.
Occorre, quindi, che il Governo si adoperi affinché alle vittime e alle persone danneggiate dal reato sia riconosciuta una tutela di rango costituzionale affinché nel nostro Ordinamento possano essere recepite le indicazioni previste dalle varie Direttive Europee del tutto ignorate.