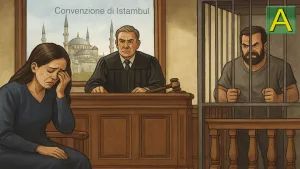La Giustizia Riparativa nell’Ordinamento Penitenziario
Nelle legislazioni occidentali la Giustizia Riparativa costituisce una nuova frontiera per una possibile risposta al reato che coinvolge il reo e,direttamente o indirettamente,la Comunità e/o la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni riparatorie degli effetti dell’illecito e nell’impegno fattivo dell’autore del reato per la riparazione delle sue conse guenze.
| Mercoledi 19 Giugno 2024 |
In tale ottica,il fenomeno criminoso viene letto non solo come trasgressione di una norma e lesione (o messa in pericolo) di un bene giuridico, bensì come evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali che richiede l’adoperarsi per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
In particolare, la Raccomandazione (99)19 emanata dal Consiglio d’Europa definisce come Gustizia Riparativa quel procedimento in cui "la vittima, il reo ed ogni altro individuo o membro della comunità,lesi da un reato,partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall’illecito penale, generalmente con l’aiuto di un facilitatore"(o mediatore penale NdR )ossia quel"procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore)"
Le disposizioni introdotte prima della Riforma Cartabia
Come ricorda la Dottrina (v. A Diddi - Effetti sull'esecuzione penale e penitenziaria della Restorative Justice) da tempo il diritto penitenziario si è confrontato con il modello della Giustizia Riparativa; anzi si può dire che la crescente attenzione,non solo del legislatore, verso il tema abbia preso le mosse proprio dal delicato settore in questione.
Già in precedenza, nella fase di esecuzione della pena ed, in particolare,nell’ambito delle misure alternative alla detenzione,durante l’affidamento in prova al servizio sociale,l’art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354 al comma 7 aveva già stabilito che “nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare”; come pure durante la liberazione condizionale, di cui all’art. 176 c.p., nell’ ambito delle prescrizioni che il giudice può impartire al soggetto in regime di libertà vigilata, oppure, nell’ ambito dei presupposti richiesti dal giudice per la sua concessione (atteso che l’art. 176 c.p. richiede un comportamento “tale da far ritenere sicuro il ravvedimento del reo”).
Poco dopo l’approvazione del regolamento del 2000 (d.p.r. n. 230/2000), con Decreto 26 febbraio 2002 venne istituita una Commissione di studio sull’importante argomento nell’intento di definire le linee guida per l’adozione di modelli uniformi per gli interventi di Giustizia Riparativa in base a quanto disposto con la dichiarazione di Vienna del 2000 e la risoluzione 27 luglio 2000, n. 2000/14 sui principi base sui programmi di Giustizia Riparativa in ambito penale emanate dall’Economic and Social Council.
Con la Circolare 3601/6051 del 14 giugno 2005 erano, poi, state elaborate linee guida per la uniforme applicazione dei modelli operativi sul fenomeno
Nel 2009,il DAP,con Ordine di Servizio n. 1003 del 21 gennaio 2009, preso atto dell’incremento delle richieste di incontri di mediazione tra reo e vittima avvenuto a seguito delle prime esperienze avviate,aveva effettuato una ricognizione su scala nazionale delle Associazioni e Cooperative di mediazione ed in particolare dei mediatori disponibili a collaborare ad una sperimentazione di incontri tra rei e vittime, a titolo gratuito.
L’iniziativa aveva riscosso successo e con Ordine di Servizio del 17 settembre 2014, n. 1148, il DAP aveva provveduto a dare nuovo impulso all’attività dell’Osservatorio sulla Giustizia Riparativa e la mediazione penale che veniva,tuttavia,interrotto nel 2012.
Sta di fatto che il DAP,dopo la emanazione della Direttiva 2012/29/UE del 23 ottobre 2012, stabiliva che “nella fase in cui vengono pronunciate misure che contemplano il maggior ricorso ad attività ispirate alla “Giustizia Riparativa“ ,riteneva opportuno richiamare l’attenzione degli Operatori Penitenziari, “sull’opportunità di promuovere l’innesto delle politiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna o detentiva con modalità coerenti con i principi fondanti la Giustizia Riparativa” .
Tuttavia,In assenza di un quadro di riferimento organico, i dati normativi sui quali avviare le attività di Giustizia Riparativa ante litteram erano costituiti dall’art. 27 d.p.r. n. 230/2000,in base al quale,”nel corso dell’ osservazione scientifica della personalità,va espletata, con il condannato e l’internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo, come pure sulle possibili azioni di riparazione delle conse guenze del reato, incluso il risarcimento dovuto la persona offesa“ e dall’art. 118 del Regolamento,che, a proposito delle attribuzioni del centro di servizio sociale per adulti, stabilisce che “gli interventi del medesimo nel corso del trattamento in ambiente esterno,sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabil mente gli impegni che derivano dalla misura a cui sono sottoposti”.
Tali attività andavano,comunque,coordinate con quanto stabilito dall’art. 47 della Legge 354/1975 che, in base al comma 7 “deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente gli obblighi di assistenza familiare”.
Un momento particolare di questo processo evolutivo si riscontrava anche nei lavori degli Stati Generali sull’esecuzione della pena, istituito nel 2015 dal Ministro Orlando allo scopo di fornire al Governo suggerimenti su possibili interventi normativi, rimastii tuttavia senza esito,ance se sanciti dalla Legge Delega n.103/2017..
Tuttavia,grande attenzione veniva rivolta dagli studiosi alla Giustizia Riparativa,in linea, peraltro, con la dottrina più autorevole che aveva evidenziato l’opportunità di estenderla anche nella fase dell’esecuzione della pena detentiva.
Le innovazioni introdotte dalla Riforma
L’integrazione operata dal Legislatore alla normativa precedente è derivata,quindi, dall’importanza attribuita alla stessa ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione avanzata con la richiesta di accesso del condannato di accedere alla Giustizia Riparativa che si conluda con un esito positivo.
La Riforma Cartabia si è preoccupata,pertanto,di assicurare attività riparative anche nella fase della Esecuzione Penale attraverso la introduzione ex novo dell’art.15 bis nella Legge dell'Ordinamento Penitenziario,che sancisce testualmente
1. In qualsiasi fase dell'esecuzione,l'Autorità Giudiziari può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di Giustizia Riparativa.
2. La partecipazione al programma di Giustizia Riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale.
Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interru zione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.
La norma è stata inserita con l’art.78, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che,a decorrere dal 30 dicembre 2022, dispone testualmente:
-
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all'articolo 13, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
-
«Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di Giustizia Riparativa.»;
-
dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Giustizia Riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di Giustizia Riparativa.
-
La partecipazione al programma di Giustizia Riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonche' della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;
-
all'articolo 47:
1.dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. L'affidamento in prova puo' altresi' essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semiliberta' sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno meta' della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia piu' idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri
reati.
Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»;
2.al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» e' inserito il seguente periodo: «A tali fini e' valutato anche lo svolgimento di un programma di Giustizia Riparativa e l'eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «gia' riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita».
In conseguenza ,come sottolinea la Dottrina (v. A Diddi,op.cit.), sono divenuti accessibili i programmi di Giustizia Riparativa anche in sede esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, come definiti dall’art. 44 del d.lgs. 150/2022,
In base a tale disposto,sia la vittima del reato che la persona condannata con pronuncia irrevocabile possono accedere ai programmi ripaatori con la mediazione penale tendenti a promuovere il riconoscimento della vittima,la responsabilizzazione dell’autore del reato, la ricostruzione dei legami con la Comunità,a prescindere dalla fattispecie di reato e dalla sua gravità.
In conseguenza lil citato art. 78 ha,anzitutto,disposto l’introduzione di una norma di carattere generale nella legge. 354/1975,costituita dall’’art. 15-bis che, in ideale continuità con il citato art. 44,in base al quale ai programmi di Giustizia Riparativa si può accedere ora in ogni stato e grado del procedimento, ed in collegamento con il pur controverso e discusso art.129-bis c.p.p. in base al quale “in ogni stato e grado del procedimento l’Autorità Giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato al centro di Giustizia Riparativa per l’avvio di un programma di giustizia ripartiva”, senza migliore precisazione, per quanto si dirà oltre. stante la differente fase per la sua concreta applicazione e la sua specificità..
La norma procedurale richiamata stabilisce,quindi,che la Giustizia Riparativa sia accessibile al condannato“in qualsiasi fase dell’esecuzione”,ed individua nell’art.45-ter disp. att. c.p.p., il “Giudice competente in ordine all’accesso alla Giustizia Riparativa“ dal momento dell’esercizio dell’azione penale e fino al ricorso per cassazione.
In mancanza di una norma specifica e ricorrendo alla medesima disposizione introdotta per gli imputati e le Vittime di Reato,l’Autorità Giudiziaria può, quindi, disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di Giustizia Riparativa.
Inoltre,tale previsione di carattere generale va coordinata:
a) con l’art. 656 c.p.p. (modificato dall’art. 38 del d.lgs. n. 150/2022) a mente del quale l’Ordine di esecuzione contiene,tra l’altro, l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa;
b) con l’art. 13, comma 4, dell’O.P. (modificato dall’art. 78 d.lgs. n. 152/ 2022) secondo cui “nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di Giustizia Riparativa”.
c) con il comma 2 dell’art. 15-bis dell’ O.P.in base al quale “la partecipazione ai programmi di Giustizia Riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione di permessi premio, delle misure alternative alla detenzione nonché della liberazione condizionale”.
Per completezza occorre aggiungere che la Riforma ha introdotto anche alcune modifiche alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni inserendo ,all’interno del d.lgs. n. 121/2018, una disposizione corrispondente a quella dell’’art.15-bis citato in base alla quale “in qualsiasi fase di esecuzione, l’Autorità Giudiziaria può disporre l’invio dei minorenni condannati,previa adeguata informazione su base volontaria,ai programmi di Giustizia Riparativa“.
Fatta questa breve premessa, è opportuna anche l’indicazione delle norme, innanzi richiamate, dell’O,P.e le altre leggi ancora vigenti in materia e la loro effettiva applica zio ne,al fine di operare un raccordo della Giustizia Riparativa con il trattamento e le attività rieducative per i condannati,poiché,come sancito dall’art 27 della Costituzio ne,“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Innanzi tutto,un generico riferimento alla necessità di mediazione con la Vittima si ravvisa nell’art.47,comma 7 dell’O.P.,che prevede che tra le prescrizioni dell’affidato in prova al servizio sociale,che questi “si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”e che “la misura alternativa va adottata sulla base dei risultati della osservazione della personalità” come già ricordato..
Inoltre,tale previsione va vista in relazione all’art. 27 del Regolamento penitenziario (DPR 30 Giugno 2000 n.230)laddove, nella parte relativa alla “osservazione della personalità” del condannato, stabilisce che l’ Equipe di trattamento operante in carcere svolga con questi una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e “sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato”, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
Il successivo art.118 comma 8 dello stesso Regolamento prevede,inoltre,che gli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) si adoperino a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona condannata, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”.
Occorre,inoltre,menzionare gli altri riferimenti normativi sullo stesso tema:
a. L’art.165 C.P.“Obblighi del condannato”,nel testo riformato dalla Legge 145/2004 che,nel considerare la sospensione condizionale la subordina ad azioni riparatorie per le conseguenze dannose o pericolose del reato.
b. La Legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”,che agli artt. 101e ss.,sancisce la possibilità di prestare “lavoro sostitutivo”,consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività per la riparazione dei danni arrecti alla Comunità.
c. L’art 176 del C.P. che subordina l’ammissione alla liberazione condizionale “all’adempi mento delle obbligazioni civili derivanti dal reato”ed al”sicuro ravvedimento del condan-nato”.
d. La Legge 9 agosto 2013 n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78),recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena,che,nel modificare l'articolo 21 dell’O.P: “Lavoro all’esterno”, prevede che i detenuti possano fruire di tale beneficio anche per prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito,tenendo conto delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, per la esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della Collettività, ovvero a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
e. La Legge 28 aprile 2014 che,oltre a far riferimento a prestazioni di lavoro di pubblica utilità e a forme di risarcimento del danno e di restituzione, enuncia alcune condotte riparatorie attribuendo compiti precisi agli Uepe.
In particolare la legge,al Capo II - art 3,stabilisce che la messa alla prova “comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché,ove possibile,il risarcimento del danno cagionato dallo stesso”
Nel successivo punto,a proposito del programma di trattamento,si fa riferimento, tra l’altro, ad attività di volontariato di rilievo sociale e che la concessione del beneficio è subordinata a prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestazioni non retribuite in favore della Collettività che, nell’intento del Legislatore appare come un percorso virtuoso da conseguire che, tuttavia,va contemperato con le esigenze ristorative della Vittima.
Le attività riparatorie in favore delle Vittime
Veniamo al punto dolente della normativa applicabile innanzi esposta che, in verità, assegna un ruolo marginale alla Vittima nel corso del procedimento riparatorio.
Tale considerazione va fatta con riferimento a quanto sancito nel nuovo art. 13 Ord. Penit.,introdotto con la Riforma,il cui terzo comma recita:
“Nell'ambito dell'osservazione,è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso,sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”.
Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere che l’accesso alla Giustizia Riparativa in fase esecutiva costituisca un rimedio per il condannato a cui ricorrere per beneficiare delle misure alternative alla detenzione, la norma risulta essenziale per fornire una corretta risposta alle varie istanze delle Vittime rimaste insoddisfatte nel corso del processo e che, a fortiori, devono essere suscettibili di protezione anche dopo la sua conclusione e, addirittura, nel corso della esecuzione della pena.
Invero,se il principio più rilevante introdotto dalla Riforma è quello di prevedere la possibilità di accedere ai programmi di Giustizia Riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante la esecuzione della pena.le norme procedurali non assegnano alcun ruolo decisorio alla Vittima tanto meno un diritto all’impugnazione stante la discrezionalità del provvedimento assunto,in questo caso, dal Tribunale di Sorveglianza..
Inoltre,la Riforma amplia notevolmente il concetto di Giustizia Riparativa, ricompren- dendo in esso sia strumenti che in realtà rientrano nell’alveo di quelli premiali e con indubbia valenza deflattiva del procedimento penale (come ad es. la messa alla prova),
Sul punto l’art.43 del d. lgs. 150/2022 individuai i principi,gli obiettivi e le garanzie per verso cui tende senza assegnare alcun ruolo alla Vittima, spettatore silente anche in fase esecutiva delle decisioni assunte che pure la riguardano direttamente.
La nuova normativa sancisce:
-la partecipazione attiva e volontaria al procedimento;
-l’eguale considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa;
-il coinvolgimento della Comunità, poiché l’art. 45 consente la partecipazione ai programmi anche dei familiari della vittima e dell’autore del reato, nonché di enti e associazioni, poiché gli effetti del conflitto spesso si riverberano in ambiti più ampi di quelli reo-vittima;
-la riservatezza che costituisce la condizione indispensabile che assicura,da una parte, lato la genuinità dei percorsi riparativi siccome protetto dalla confidenzialità e, dall’altro, rende compatibile l’esperimento di un programma anche nella fase della cognizione facendo salva in primo luogo la presunzione di innocenza che, unita alla inutilizzabilità, assicura la genuina acquisizione della prova sia nella fase delle indagini che nella fase del processo;
-l’indipendenza dei mediatori e la loro terzietà rispetto ai partecipanti, principio cardine delle pratiche di Giustizia Riparativa.
E’ importante segnalare,infine,due importanti criteri che, soprattutto per i Magistrati, dovranno guidare i loro interventi:
1)che l’accesso ai programmi di Giustizia Riparativa può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti derivante dallo svolgimento del programma stesso (art. 43 co. 4).
Il principio di libera accessibilità ai programmi riparativi è tendenzialmente assoluto ma vede come unico limite il pericolo per l’incolumità dei partecipanti e, dunque, il Giudice potrà impedire l’accesso ai Centri allorché dalla partecipazione stessa al programma possa derivare un qualche concreto pericolo all’autore del reato.
2) che la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa (art. 58 co. 2).
Questo significa che nell’ambito del procedimento penale solo il raggiungimento di un “esito riparativo” può svolgere alcuni effetti a favore dell’imputato o del condannato, essendo l’intera disciplina dal divieto di valutazione in malam partem dell’eventuale fallimento del programma, colpevole o incolpevole che possa essere.
All’Autorità Giudiziaria verranno solo comunicate la mancata effettuazione del program ma,l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 57).
È infine previsto che l’Autorità Giudiziaria valuti lo svolgimento del programma e l’eventuale esito riparativo per le determinazioni di competenza, anche ai fini di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), fermo restando che la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non possono comunque produrre effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.
Si può,quindi,ritenere che tale impostazione normativa renda perfettamente compatibile l’innesto della Giustizia Riparativa con i principi regolatori del procedimento penale italiano primo fra tutti quello della presunzione di innocenza(art 27 Cost. cit.).
Nondimeno,va sottolineato che se tale principio trovi la sua necessaria applicazione in tutto il corso del giudizio ordinario sino alla Cassazione,diversa appare la situazione dopo la messa in esecuzione della pena per la quale occorrerebbe intervenire con efficacia per “tentare” di assicurare ala Vittima un giusto ristoro dei danni patiti.
In effetti, la normativa in commento si occupa anche della disciplina che riguarda i diritti, le garanzie e di doveri dei partecipanti, i doveri dei mediatori, lo svolgimento dei programmi, quella sulla valutazione dell’esito dei programmi da parte dell’Autorità giudiziaria,gli innesti processuali e sostanziali e sulle leggi speciali,la esecuzione penale,con l’introduzione di un nuovo articolo 13 nell’O.P, innanzi ricordato. ed, infine, la formazione e i requisiti dei mediatori esperti di mediazione penale che vanno individuati anche tra gli Operatori Penitenziari, come sarebbe auspicabile..
Sul punto occorre sottolineare che il Ministero della Giustizia ha dettato regole per la formazione dei mediatori senza introdurre alcuna specifica disciplina per la fase della esecuzione penale per i quali sarebbe stata opportuna una distinzione per la delica tezza delle materie trattate e del ruolo ricoperto come pure per il tirocinio necessario in ambito carcerario..
Tanto meno la nuva normativa individua le caratteristiche dei Centri di Giustizia Riparativa per i detenuti e le caratteristiche dei locali dove svolgere le attività di mediazione per garantire uno svolgimento in linea con le necessità di sicurezza dei partecipanti come innanzi evidenziato.
Si tratta di un passaggio delicato perché l’attuazione del modello riparativo,oltre alle difficoltà che la sua applicazione di per sé pone in un ambiente conflittuale normale, deve fare i conti con il contesto carcerario (!!).
La norma di riferimento,da applicare in tali casi,non può essere l’art 56 d.lgs. n. 150/2022 che afferma come l’esito riparativo può essere simbolico o materiale, come.
Al contrario,sostenuto dalla Dottrina citata(v. A Dindi, op. cit).. .
Entrambe le ipotesi innanzi delineate sembrerebbero delineate per un contesto in cui “autore del reato” e “vittima” sono in condizione di potersi muovere con una certa libertà d’azione e su piani di tendenziale parità mentre è dato dubitare di tale assetto ideale.
A parte le «dichiarazioni» o le «scuse formali» – certamente realizzabili anche da chi si trovi in vinculis – è difficile immaginare che un detenuto o un internato possa assumere e svolgere «impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone e luoghi»;«risarcimenti danni»; «provvedere a restituzioni»,«adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze danno se o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori».
Se la Giustizia Riparativa, poi, presuppone un dialogo tra autore del reato e vittima, e la partecipazione della Comunità al ripristino del rapporto con l’autore della violazione,è facile pensare che molti ostacoli si frapporranno alla realizzazione di tali percorsi riparatori che sono,comunque, legati alla gravità del reato commesso..
E’ pensabile,invece,che l’unica forma che troverà concreta applicazione sarà il lavoro all’esterno di pubblica utilità di cui all’art.20-bis ed il lavoro a favore della vittima e della sua famiglia ai sensi dell’art. 21, comma 4-bis, della l. n. 354/1975, istituti questi che,la citata Circolare del 2005 considerava come una delle possibili modalità applicative del paradigma riparativo e che oggi,per effetto di quanto dispone l’art. 15-bis,può essere concesso per partecipare ai programmi riparatori in condizioni differenti da quelle ipotizzate dal Legislatore. .
Conclusioni
In definitiva, l’inserimento della Giustizia Riparativa in sede esecutiva è caratterizzato da molte luci ma anche da alcune ombre, come si affermano i commentatori.
Sebbene, per quel che si è osservato, la Giustizia Riparativa rappresenti un’importante opportunità,essa non costituirà quella rivoluzione copernicana o quel nuovo paradigma entro il quale ripensare la Giustizia Penale che, secondo alcune opinioni, ci si appresta a vivere con il suo recepimento nel sistema.
Essa, come tutto quel che appartiene al più ampio tema della riparazione intesa in senso lato, ha anzitutto il merito di completare un sistema con l’ingresso della Vittima anche nella fase esecutiva così colmando una lacuna dell’Ord. Giudiziario pregresso. .
La ricerca del dialogo tra condannato e vittima; tra autore del reato e Comunità, svolgono certamente l’importante funzione di far entrare i soggetti sui quali normalmente ricadono gli effetti dell’illecito,in una fase del procedimento dalla quale erano stati sempre tradizionalmente esclusi.
Laddove sia ben organizzata,la Restorative Justice potrà operare come momento significativo per la trasformazione di una pena – quella carceraria – che oggi non soddisfa più nessuno, né la vittima, né la Società, sempre più distaccate dai misteri del processo ed incapaci di comprendere le dinamiche dei percorsi esecutivi, ma, soprattutto, contribuirà a dare nuovi e più moderni contenuti ai programmi di tratta mento rieducativo e di recupero del condannato in base a quanto sancito dalla Costituzione..
Inoltre essa potrebbe costituire un punto fermo per impostare una revisione comples siva dell’esecuzione penale ispirata davvero al principio di flessibilità della pena e, non ultimo, avviare il Sistema Carcerario verso un nuovo modello del trattamento sanzionatorio alternativo che consenta la deflazione dei detenuti e,soprattutto,nel rispetto della Costituzione