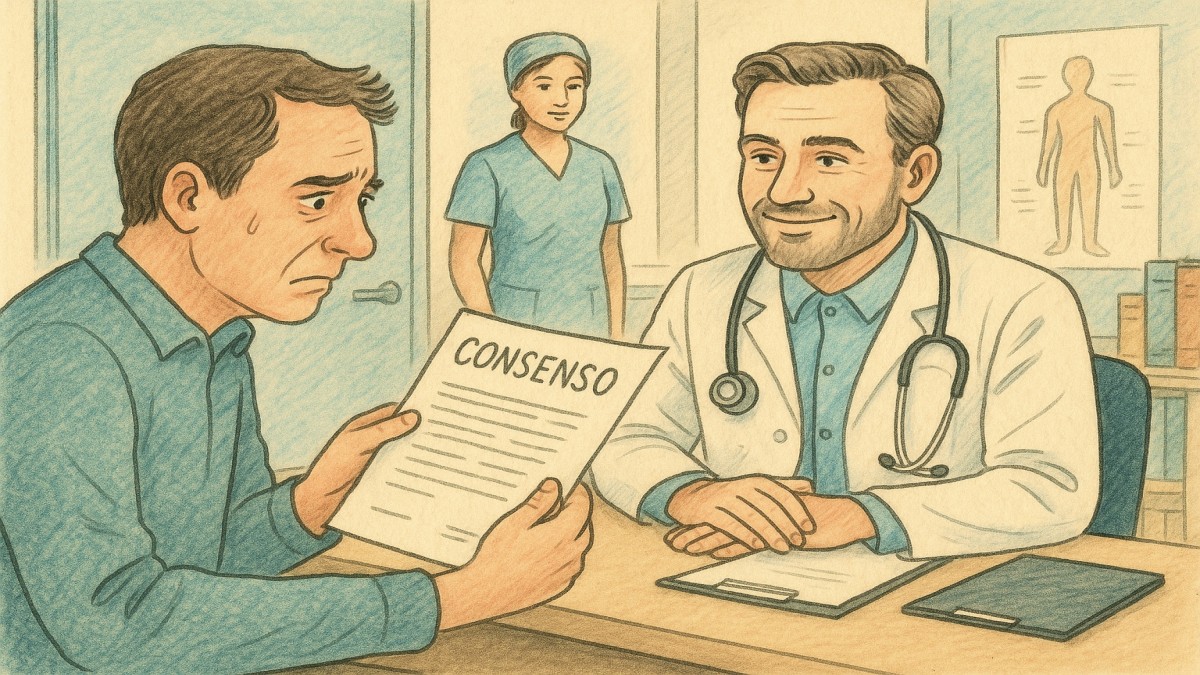Una personale riflessione sulle conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente
Rispetto alla violazione dell’autodeterminazione in medicina veterinaria, che non poche volte ho trattato e della quale spesso mi occupo, in medicina umana le cose sono certamente diverse per quanto riguarda il rispetto della normativa.
| Venerdi 29 Agosto 2025 |
Ecco, la normativa. Quella che dovrebbe garantire l’applicazione del consenso informato, principio che segna, avrebbe dovuto segnare, il definitivo passaggio da un prima e un dopo. Un prima in cui il protagonista assoluto, depositario della verità scientifica, custode unico del sapere, era il medico. Un dopo dove il consenso informato avrebbe dovuto rappresentare l’esito di un percorso pomposamente chiamato “alleanza terapeutica” tra paziente e medico. Nulla di strano se analizziamo il consenso informato come espressione del diritto. Terminologia aulica, linguaggio, quello del diritto, retorica. Una promessa come lo è quasi ogni nuova norma.
La domanda successiva è se davvero si tratti di alleanza terapeutica o invece solo di apparente alleanza. Che non può essere rappresentata da quel documento che spesso, solo siglato dal paziente, vorrebbe o dovrebbe significare che quello dichiara di essere stato consapevolmente informato dal medico.
Considerazione forse banale quest’ultima, ma è proprio all’interno di questa banalità che si nasconde il limite del consenso informato. Che oltre che informato (se non vi è informazione non vi può essere consenso e alcun senso avrebbe una eventuale firma se non quella di considerare provata l’incombenza del medico) deve essere consapevole, completo (deve riguardare cioè tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili), globale (deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), esplicito e non meramente presunto o tacito. Consapevole, completo, globale, esplicito, così da garantire una scelta libera, volontaria, e cosciente da parte del paziente.
Ma è solo immaginabile che ciò accada nella realtà quotidiana delle nostre strutture sanitarie? Oppure è esattamente (e solo) quello che “promette” la norma, quella legge n. 219/2017 che finanche espressamente ci dice che la relazione di fiducia tra paziente e medico costituisce parte della cura. A volere essere generosi il paziente rilascia il proprio consenso solitamente nella imminenza di sottoporsi ad una prestazione sanitaria (visita, esame diagnostico, intervento) dove la sua determinazione è forse limitata ad augurarsi che tutto vada bene e possa quel medico risolvere il suo problema (la c.d guarigione). Dimenticando, o solo postponendo alcune considerazioni che potrebbero riguardare il post intervento, la gestione di eventuali rischi e complicanze, eventuali limitazioni future riguardanti il proprio stile di vita o modus vivendi.
Possiamo davvero immaginare che in un sistema sanitario, pubblico o privato che sia, subordinato alla legge dei grandi numeri (più numero di interventi maggiore i profitti per le strutture sanitarie) si possa realisticamente parlare di attuazione della alleanza terapeutica? Spesso non conosciamo il nome del professionista che ti opererà o ti ha operato. Ecco lo svantaggio che quella legge 219/17 non ci racconta. Che è invece un vantaggio potenziale per il personale medico, messo in sicurezza da eventuali richieste risarcitorie “aggiuntive” a quelle comunque sempre esperibili dal paziente per accertanda malpratica. Il danno discendente dalla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente è concettualmente diverso da quello conseguente all’inadempimento della prestazione principale di cura da parte del medico.
Temo che oggi, a ormai 8 anni dall’entrata in vigore della legge, il paziente interpreti quel modulo solo come una sorta di liberatoria per sollevare operatori e strutture sanitarie da responsabilità. Un atto amministrativo dovuto e necessario per essere destinatario di una certa prestazione sanitaria. Temo sia inesistente (o forse molto difficile) quel promesso supporto al paziente perché possa esprimere una decisione libera e consapevole.
E’ vero che la prova di aver correttamente adempiuto all’obbligo informativo spetta ai sanitari, ma la norma non dice quanto diabolica sia la prova che deve offrire il paziente per dimostrare che, se correttamente informato, non avrebbe acconsentito a quella certa prestazione. Va infatti considerato che anche in materia di violazione del consenso informato non sono consentiti meccanismi risarcitori automatici. Il paziente, o i suoi eredi, dovranno allegare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione e verificatasi a seguito di un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato. Attesa infatti la natura contrattuale della responsabilità in oggetto, a fronte dell’allegato inadempimento da parte del paziente grava sul medico l’onere di provare il corretto adempimento dell’obbligo di informazione preventivo spettando al medico, in particolare, provare di avere fornito al paziente "informazioni dettagliate idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative" (così, tra le altre in termini, Cass. 4.2.2016, n. 2177; Trib. Torino sent. 2222/2025). Non solo. Le conseguenze dannose, come insegna la giurisprudenza anche recente, per essere rilevanti a fini risarcitori devono superare una valutazione di gravità e serietà. Si veda sul punto Corte appello Bologna sent. n. 844/2025.
Proprio questa percezione che si ha del consenso informato come appena delineata credo ne infici il suo significato. Un consenso informato percepito come un “salvataggio” per il medico ed eventualmente come strumento di ritorsione nei confronti dello stesso, se usato dal paziente. Con i limiti ai quali ho solo accennato. Nell’interesse di quale principio è stato pensato quel consenso consapevole, completo e globale? Di quel richiamato principio di alleanza terapeutica tra un soggetto, il medico, ultra specialista, che lavora in equipe, che parla un’altra lingua, appunto specialistica, incomprensibile, tecnologicamente e sempre più avanzata e inarrivabile per l’uomo medio. Certo il medico deve adattare il linguaggio in relazione a chi ha davanti. Deve essere in grado di mutare il linguaggio a seconda di che cosa? Del titolo di studio, di quanto il medico ritine possa comprendere o di quanto preoccupato sia il paziente? Non lo dice la norma.
Questa promessa ha ad oggi un ineliminabile limite laddove l’ “altro alleato” è una persona che verosimilmente ha un solo e unico interesse che è quello di guarire, ad ogni costo. Assorbito dai suoi pensieri, dalle sue preoccupazioni. Forse solo ostaggio di un antico e mai superato timore reverenziale nei confronti dii una figura ancora ritenuta ieratica. Se alleanza terapeutica significa relazione medico-paziente è difficile individuarla in un freddo pezzo di carta da sottoscrivere. La cui firma dovrebbe essere l’ultimo atto di una relazione iniziata prima in cui entrambe le parti “dovrebbero” tendere ad un unico fine. La ricerca della cura. Quella ricerca della cura (tempo di cura) che è anche parte della prestazione sanitaria che però non è quella dedotta nel contratto tra medico e paziente. Non lo è perché in quel contratto è dedotto un interesse strumentale (quello che il medico adempia secondo le leges artis) a quello primario, non contemplato nel contratto, che è la guarigione. Un interesse che appartiene al paziente. Solo a lui, il quale nel momento della malattia potrebbe avere una sua visione del mondo diversa e differente da quando la malattia non aveva ancora preso il sopravvento. E dunque una sua propria autodeterminazione inficiata da quella stessa patologia.